Un caso di ordinario mobbing

Un capo nuovo, una donna, dopo tanti uomini. Ero curiosa – preoccupata, sì, anche – ma soprattutto curiosa di conoscere questa persona e cercare di instaurare con lei un buon rapporto fin da subito. Quello che avevo creato con tutti i miei responsabili prima di lei. Volevo cercare di metterla a suo agio, aiutarla ad ambientarsi nel nuovo ufficio dandole dritte che le avrebbero risparmiato un po’ di fatica: a me era sempre stato utile ascoltare i consigli dei veterani, quando arrivavo in una struttura nuova. Ho sempre apprezzato infinitamente chi cercava di farmi integrare, di rompere il ghiaccio.
E lei si dimostrò accomodante e propositiva. Empatica.
Che bello – pensavo – sono stata fortunata ancora una volta. Perché nella mia vita professionale sono sempre stata molto fortunata. Ho sempre avuto colleghi che si sono dimostrati persone corrette, oneste e con le quali spesso il rapporto di lavoro si era trasformato in amicizia. Mai un colpo basso, solo cooperazione costruttiva che permetteva a tutti di lavorare bene e in armonia. Del resto io sono sempre stata una che ama il lavoro di squadra e non ha mai sgomitato per mettersi in luce a discapito dei colleghi.
Invece, il fatto di aver sempre vissuto in ambienti di lavoro sereni mi aveva fatto sottovalutare completamente la possibilità che questa volta poteva essere diverso. E questa volta, ahimè, era diverso. La donna a cui ora riportavo non tardò a rivelarsi una persona machiavellica, che aveva in testa un disegno preciso, una strategia che iniziò ad attuare fin da subito: mettere in difficoltà la vecchia squadra (me e il resto del team di persone che aveva trovato al suo arrivo) fino a esasperarla mettendola nelle condizione di andare via, per creare a poco a poco la ‘sua’ squadra, fatta di persone con cui lei aveva lavorato bene nelle aziende precedenti. E mano a mano che le sue persone venivano assunte, le vecchie (noi!) venivano demansionate biecamente, mobbizzate, umiliate.
Io ero tornata da pochi mesi in azienda dopo la nascita del mio secondogenito ed ero nel delicato periodo dell’allattamento. Per me che avevo a casa un bambino di pochi mesi, uscire dall’ufficio due ore prima dell’orario canonico era un diritto a cui non avrei mai rinunciato, e lei (pur essendo madre a sua volta) non perdeva occasione per farmi notare il fatto che non sacrificassi neanche un minuto di quel tempo sacrosanto in nome dell’azienda. Poco importava se gestivo la mia mole di lavoro con responsabilità.
“questo è un lavoro impegnativo, che non ha orari, mettetevelo in testa. I figli crescono da soli, nonostante voi” è stata la frase che, incredula, ho sentito uscire dalla sua bocca. E la cosa peggiore era che lei di quello era convinta.
Io però avevo un’opinione diametralmente opposta, ero dell’avviso che si potesse conciliare il lavoro (di sicuro, quello che svolgevo io) con la vita privata, maternità inclusa, ed ero riuscita a farlo fino a quando in azienda aveva messo piede quella donna. Anzi, il paradosso era che prima di lei avevo avuto capi di sesso maschile che mai si sarebbero sognati di mettermi i bastoni tra le ruote quando sono diventata madre, anzi. Per loro nulla era cambiato.
Era uno scontro fra titani: lei inflessibile e aggressiva, forte del fatto che ero in una posizione di subordinazione, convinta che avrei sempre ingoiato rospi e taciuto. Forse 10 anni prima sarebbe andata così, avrei sopportato logorandomi e tirando avanti. Ma ora ero una madre, ero più forte e lucida, e la sola idea di subire un sopruso così plateale era per me intollerabile. All’ennesima frase discriminatoria della signora in questione le scrissi una lettera al vetriolo con in copia l’amministratore delegato in cui denunciavo il suo comportamento scorretto e fuori luogo. Lo feci prima di tutto per difendere la mia dignità.
Come andò a finire? Vinse lei, perché diedi le dimissioni.
E lo feci dopo notti insonni e un disagio che mi accompagnò per mesi.
In realtà però, quell’esperienza sgradevole accelerò solo un processo che era già in corso, mi spinse a chiarirmi le idee: non volevo più sottostare a orari prestabiliti, volevo un lavoro più flessibile che quell’azienda (come il 99% delle aziende italiane) non poteva concedermi, perché il concetto di smart working in Italia è ancora fantascienza.
Non ho mai raccontato questa storia, perché volevo lasciarmela alle spalle e perché mi ha portato un’amarezza mai provata in vita mia. Poi però, col tempo, mi sono resa conto che quello che sembrava un fallimento che si è rivelato un’opportunità. Mi ha dato la spinta a diventare una libera professionista, mi ha aperto indirettamente occasioni nuove e inaspettate. E mi ha fatto scoprire una nuova me, creativa e risoluta, che oggi fa esattamente quello che desidera fare: lavorare (con orari flessibili) e occuparsi della famiglia senza dover delegare.
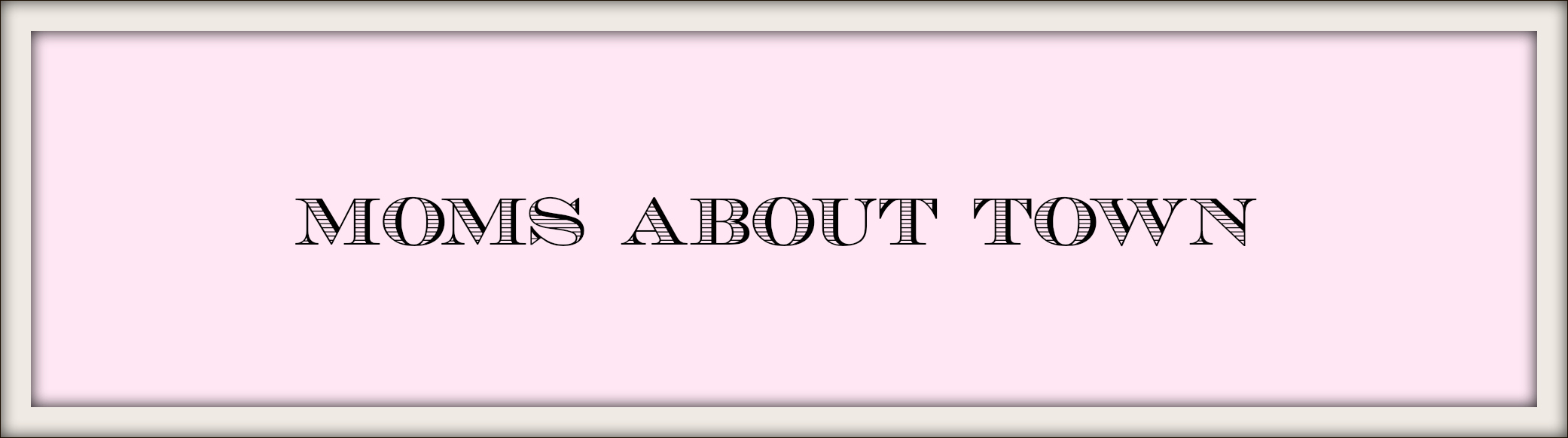





Discussion about this post